Rönnberg, Stadsgaard e Rahbek
Recuperiamo quattro dischi usciti quest’anno, in cui suonano più o meno le stesse persone, ma con assetti diversi. Tutta gente di cui sempre più spesso si sente parlare.
THE EMPIRE LINE, Syndicat De La Couture
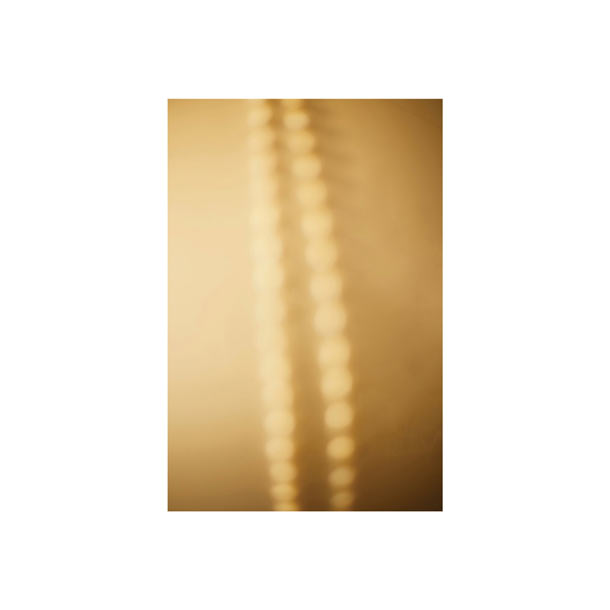
Nel 1959 Cristobal Balenciaga presenta “The Empire Line”, la sua collezione di abiti femminili più iconica, fatta di capi dalle linee essenziali e pulite, ispirati alla classicità greco-romana ma nello stesso tempo con uno sguardo all’Estremo Oriente: quello che, a detta di molti, rappresenta l’apice creativo dello stilista basco. Asciuttezza, semplicità, misura, tutti termini che mi sento di poter tranquillamente spendere per il progetto musicale omonimo nato dall’incontro fra Jonas Rӧnnberg e Christian Stadsgaard.
Li abbiamo già trovati nella traccia numero uno di “Devonian Gardens”, compilation uscita su nastro per Posh Isolation lo scorso anno, ora i due hanno inaugurato il 2017 con un ep per la berlinese Avian. Il progetto è l’ennesimo crocevia fra musicisti di area Posh Isolation e Northern Electronics: di Rӧnnberg, meglio conosciuto come Varg, mi capita di scrivere a intervalli abbastanza regolari, Stadsgaard è metà di Damien Dubrovnik, progetto noise condiviso con Loke Rahbek, altro personaggio caldo degli ultimi mesi. Come la maggior parte dei lavori provenienti da quel giro, le quattro tracce di questo disco tentano di far convivere techno, noise ed industrial legandosi a un iconografia e a un immaginario minimalista, come si conviene a certe latitudini. Nella traccia d’apertura si accumulano strati di rumore sulla base di una ritmica sottilmente perversa; sul tutto si innesta il simulacro vocale di Vit Fana, già nel progetto Body Sculptures in compagnia di Rӧnnberg. “Cafe Anglais” è diretta e incisiva, una ritmica irresistibile, basse frequenze e saturazioni; in “Jewelry Armoir” a trionfare è un senso di sospensione che defluisce in aporie noise. In chiusura la title-track è techno solcata da rumori ambientali e fischi.
Syndicat De La Couture, uscito lo scorso 23 gennaio su vinile, è un lavoro che si lascia ascoltare ben volentieri, convince con la sua grazia austera di gusto tutto nordico e si va ad inserire pienamente in percorsi stilistici dagli esiti tutto sommato ancora interessanti. (Angelo Borelli)
VARG, Nordic Flora Series Pt.3: Gore-Tex City

“Pretty capitalist, pretty sexist, elitist”, così Varg – all’anagrafe Jonas Rӧnnberg – ha di recente definito la scena elettronica underground, la stessa dei club esclusivi in cui pure ha suonato e suona, in quella che non si capisce bene se sia più una presa di distanze o una provocazione. Jonas si diverte così a interpretare sui social network il ruolo della superstar dell’elettronica, sfoggiando, non senza una certa goffaggine, piumini e copricapi griffati, esibendo video di acquisti in boutique alla moda, sbocciando senza riserbo su Instagram bottiglie di champagne; contestualmente nei suoi commenti se la prende con i dj strapagati e ipercoccolati, a suo dire, opponendo loro i “veri” musicisti, quelli che passano giorni e giorni stipati in un tour bus spartendosi due spicci in cambio del loro talento genuino. A Roma direbbero “la butta in caciara”.
Nel terzo, e ancora non sappiamo se ultimo, capitolo della saga intitolata Nordic Flora, non c’è spazio per eventuali guasconate e l’unico sfoggio è quello di una techno misurata, suonata da Varg quasi con leggiadria, dotata di quel rigore e quell’austerità a tratti solenne che non t’aspetti da un personaggio del genere. Unica concessione a una qualche forma di bizzarria è l’uso del vocoder in un paio di tracce (nella trap deviata di “Blue Line” e in “Red Line II”), espediente che, non so in voi, ma in me provoca sempre una miscela di ripugnanza ed esaltazione, un trucchetto forse oramai abusato ma che sortisce sempre un suo effetto. Per il resto troviamo i consueti ritmi quadrati, con particolare inclinazione al tambureggiamento, virati verso una deriva rumoristica e arricchiti dal ricorso al field recording. Fra gli ospiti del disco Drew McDowall, già membro di Coil e Psychic TV, e Alessandro Cortini, che con la loro collaborazione impreziosiscono quella che è la traccia più interessante del disco, “Fonus”, una tessitura drammatica e particolarmente complessa su cui viene calato un velo di foschia sintetica. (Angelo Borelli)
DAMIEN DUBROVNIK, Great Many Arrows

Nell’aprile del 1686 tale Wasa Daihachiro mise a segno 8133 tiri con l’arco in ventiquattro ore: il nuovo disco dei Damien Dubrovnik prende il nome da quella storica competizione giapponese in cui Daihachiro raggiunse lo stupefacente record. Posh Isolation, che proprio con un disco dei Damien Dubrovnik aveva dato inizio alle proprie attività, arriva con Great Many Arrows all’uscita numero duecento, mentre le frecce scoccate dal duo qui sono solo sei.
Il sesto album del duo Rahbek-Stadsgaard si contraddistingue per essere il loro lavoro più accessibile, nonché una delle prove più convincenti (l’acme resta l’ormai difficilmente reperibile Europa Dagbog del 2011, che, per converso, era disco particolarmente ostico). Le asperità del noise vengono qui limate in composizioni che, pur non discostandosi nell’atmosfera generale dalle precedenti, sono orientate verso un’orchestrazione di stampo classicheggiante. Il linguaggio adottato rimane comunque più che riconoscibile, specie se si è fatto l’orecchio ai progetti precedenti dei due: i compiti vengono ripartiti fra un’elettronica/elemento destabilizzante e gli strumenti acustici (viole, violoncelli, organi, harmonium, trombe), fonte di singolare e piacevole tepore. Le ritmiche sono praticamente assenti e le prospettive disegnate, rispetto al passato, si fanno meno anguste. “Arrow 1” e “Arrow 5” ricordano molto da vicino il Prurient di Frozen Niagara Falls: una è un crescendo orchestrale/elettronico, l’altra parte da una frase di harmonium su cui si va ad innestare la malapianta noise. “Arrow 2” è un pastiche fatto di piccoli suoni elettronici, qualche boato ma soprattutto grandi attese; in “Arrow 3” algidi panorami illustrati a volo d’uccello. Il mio dardo preferito rimane il quarto, breve parentesi ambient scandita da clangori, priva di sbavature o orpelli inutili; “Arrow 6” sono armonie che fanno timidamente capolino da mareggiate di rumore.
I Damien Dubrovnik sono ospiti dell’edizione in corso dell’Atonal di Berlino, l’album invece è già disponibile da fine giugno: il vinile è trasparente e la copertina ricalca l’estetica totalmente random delle ultime realizzazioni del duo. (Angelo Borelli)
LOKE RAHBEK, City Of Women

Loke Rahbek è un po’ ovunque. Ancora non è stato scritto qui, ma ad esempio suona nei Lust For Youth, che stanno su Sacred Bones, quindi non stiamo parlando di uno con visibilità zero e riscontri zero. Non stupisce dunque che, vista l’attenzione crescente su di lui e su Posh Isolation, Peter Rehberg lo abbia preso a bordo su Editions Mego per consentirgi di pubblicare il primo album a suo nome.
City Of Women, che potrebbe essere un riferimento a Fellini (ma è tutto da verificare/capire), è descritto da chiunque come una specie di compendio dei vari volti di Rahbek. Difficile pensarla diversamente, anche perché si tratta di brani senza una struttura rigida, realizzati e messi insieme nel corso di due anni, quasi derivassero da sketch disegnati su fogli sparsi per buttar giù subito un’idea, poi raccolti in un quaderno, tipo collage. Si potrebbe parlare di paesaggi sonori, ma questo non restituirebbe la gamma di soluzioni impiegate, in un modo che tra l’altro rende poco incasellabile l’insieme, altra cosa positiva di cui si sono accorti tutti: ci sono elementi “noise” (a inizio disco, addirittura, avrei detto che erano gli IRM) e drone, un utilizzo di synth analogici estremamente elementare, coi quali produrre un sound sgranato e malinconico (la title-track, alla fin fine, è un po’ timheckeriana), così come malinconici sono gli episodi con note sparse di piano calate in un contesto ambient/field recordings oppure “A Mess Of Love”, tra drone, minimalismo e “neoclassicismi”. Danno il loro contributo vari musicisti, tutti del giro danese di Loke (Iceage compresi) tranne mr. Dirty Beaches, ma i loro interventi sono squagliati nell’insieme, dunque per me poco individuabili.
In sintesi: brevi rappresentazioni sonore dello spleen, forse non destinate a passare alla storia, ma in qualche modo intriganti. (Fabrizio Garau)
