Quattro dischi RareNoise: WorldService Project, Bernocchi-Einheit-Quail, LEF, Edwin-Feliciati
Recensione collettiva per un pugno di dischi (alcuni hanno già diversi mesi sul groppone, ma, come già scritto, la pila sulla scrivania somiglia sempre di più alla Torre di Pisa, c’è poco da fare) della RareNoise di Londra, fondata da Giacomo Bruzzo insieme a Eraldo Bernocchi, al quale andrebbe fatto un monumento non fosse altro che per aver messo mano a quel capolavoro che fu Ashes, assieme a Raiz degli Almamegretta e a Bill Laswell.
WORLDSERVICE PROJECT, Serve

I WorldService Project, che in primavera sono pure passati dalle mie parti, al FreakOut di Bologna, sono un quintetto giunto al quarto album. Ed è buono, Serve, tra dispetti progpunk (non ho bevuto, hanno l’urgenza del punk ma la capacità di articolare e di aprire la forma del prog, e sanno coniugare le due istanze in modo del tutto credibile, pigliando il meglio da ognuna) e capriole jazzcore dal piglio sempre arioso e catchy. Un disco molto divertente, che unisce grande capacità tecnica, una visione non ottusa della musica e una sana attitudine al cazzeggio liberatorio: certe soluzioni fanno riemergere benvenutissime memorie dei Fishbone di Reality Of My Surroundings, un mastodonte uscito prima che la band di Angelo Moore avesse il suo quarto d’ora di celebrità con il video di “Swim”. Altrove il gruppo ricorda una versione meno cruda e folle di certi Mister Bungle: tastiere, sassofono, trombone, basso e batteria (occasionalmente le voci) sono tasselli di un puzzle che, al netto di qualche passaggio forse un po’ troppo piacione e non aiutato da una produzione troppo enfatica, funziona bene, in particolare nei momenti in cui le cose si fanno più psichedeliche e oblique (“Ease”, come una versione in opposition dei Fat Freddy’s Cat). In “Now This Means War” il leader Dave Morecroft dimostra di aver imparato bene l’italiano (vive a Roma), il pezzo però è un mezzo passaggio a vuoto. Interessante e peculiare l’uso a mo’ di chitarra delle tastiere, taglienti e molto (a volte troppo) rock; in generale le cose vanno meglio quando le dinamiche restano quiete, l’enfasi corale a tratti è forse troppo da stadio, ma il disco resta meritevole della vostra attenzione e sicuramente la band dal vivo è da vedere e avrà energia da vendere.
ERALDO BERNOCCHI – FM EINHEIT – JO QUAIL, Rosebud

Mood completamente diverso per questo disco, che ha oramai quasi un anno addosso, ma che meritava assolutamente di essere raccontato, anche se in breve (qui un’altra opinione). Eraldo Bernocchi alle chitarre baritone e all’elettronica, FM Einheit (fondatore degli Einstürzende Neubauten) a metalli, sabbia, pietre, strumenti edili ed elettronica, e Jo Quail al violoncello: questo l’assetto del trio che dà vita agli scenari immaginifici di Rosebud. Il suono di una fucina intima e irraggiungibile, come se Efesto fosse un archetipo del mito ma anche un demone che ognuno porta dentro di sé (“Bloom”), notizie da nessun luogo (“Ministry Of Disinformation”), un vago senso di minaccia come un sabba infernale (“Xanadu”), il miraggio gnawa di “Kangoo”, a mostrare altri orizzonti, come un dub sabbioso immaginato da Burroughs mentre stava a Tangeri a guardarsi la punta delle scarpe. Chiudono il western rarefatto (Morricone rivisto da Ben Frost? I Calexico senza gravità?) di “A Moment” e la preghiera orientale “The Inquirer”, celeste e impalpabile, sino al finale in cui stacca un inno di polvere e gloria a chi regge i fili del cielo che anche stavolta ha deciso di non crollarci addosso. O forse lo ha già fatto e questo è il suono delle rovine, chissà. Un disco capace di regalare visioni e che sarebbe perfetto come colonna sonora per un film di fantascienza o che parli semplicemente di altrove, dove tutti abbiamo bisogno di andare, anche quando non ci pensiamo. Da recuperare.
LEF, Hypersomniac
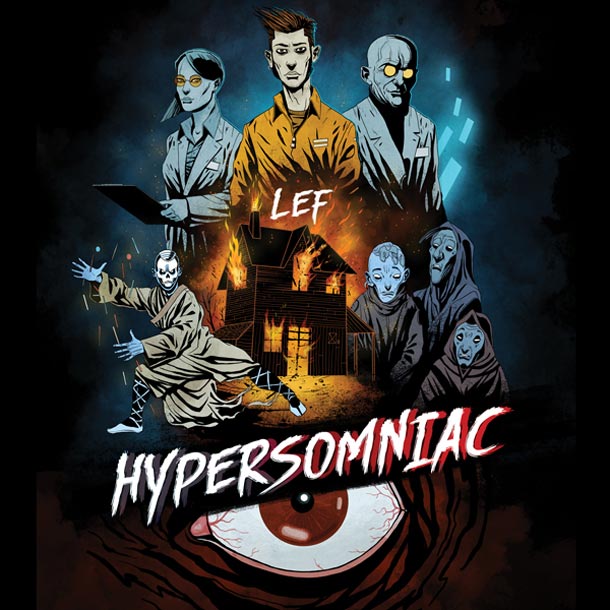
Parterre de rois per l’esordio solista del bolognese Lorenzo Esposito Fornasari (già con gli Obake): Rebecca Sneddon (Free Nelson Mandoomjazz) al sassofono, Eivind Aarset a chitarra ed elettroniche, Nils Petter Molvær alla tromba (magnifico il suo Khemr su ECM), Bill Laswell al basso, Ståle Storløkken, già con Supersilent e brevemente anche con Motorpsycho, a organo hammond e tastiere, e infine l’ex batterista di Motorpsycho (ci ha suonato per dieci anni), Kenneth Kapstad. Parte di un progetto multimediale che comprende anche un fumetto digitale e una colonna sonora (potete vedere tutto qui), il disco apre il sipario su un frammento che ci offre un sussurro sciamanico per poi virare bruscamente verso ruggini di certo prog rock (“Parallel Powers”) che peccano di presunzione. Una scrittura rivedibile (“Aran Has Changed”) che trova lampi di ispirazione nei frammenti più anarchici (“Surgery”) o quando ci consegna memorie virate seppia del David Sylvian di Secrets Of The Beehive (“It’s Alright”). Tra jam strumentali scontrose (“First Day Of Work”) e numeri da opera rock che sarebbero anche avvincenti ma pagano uno scrittura un po’ calligrafica (“Therapy”), il disco resta a metà del guado: come noi, che rimaniamo in attesa degli sviluppi futuri.
COLIN EDWIN & LORENZO FELICIATI, TwinScapes vol.2, A Modern Approach To The Dancefloor
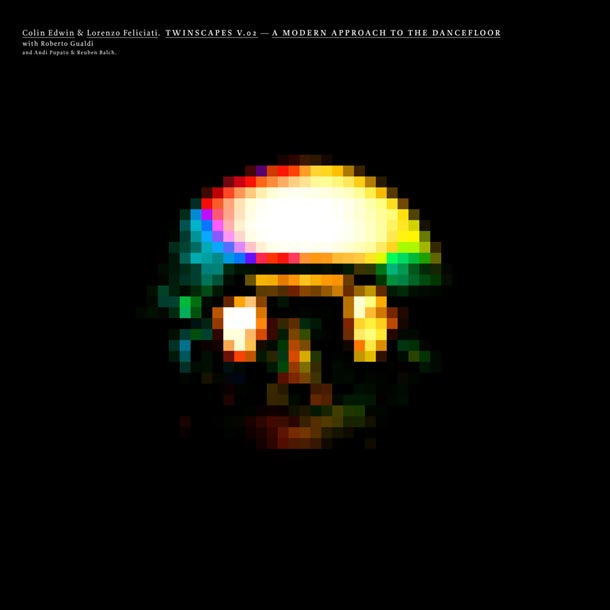
Chiudiamo questa breve rassegna del foltissimo catalogo RareNoise con il secondo lavoro del duo dei bassisti Colin Edwin (Porcupine Tree) e Lorenzo Feliciati, con Roberto Gualdi alla batteria. A perfetta testimonianza dell’eclettismo dell’etichetta (ma non è detto che questo sia sempre un bene), siamo a questo giro di ruota in pieni anni Ottanta, tra synth pop, post-punk, new wave e memorie prog; “Tin Can” suona come un incrocio tra Can e Wall Of Voodoo (ti aspetti l’arrivo del vocione inconfondibile di Stan Ridgway da un momento all’altro), “Severing Suns” – dopo un inizio che promette meraviglie – si perde in un mood interlocutorio, “Bedroom Corner” ha uno sviluppo da suite pur avendo durata contenuta, ma le soluzioni non sono convincenti. È un mood generale che pende pericolosamente verso la fusion più algida a lasciarmi un po’ perplesso: ci sono idee, talento da vendere, ma sia la scelta della tavolozza timbrica che la costruzione dei pezzi sanno di laboratorio, lasciano un senso di freddezza, di distanza. A volte (“Future Echo”) manca un’idea forte a reggere le fila, altre il pezzo passa quasi senza che ce ne accorgiamo (“In A Haze”); fuori fuoco anche “Precipice”, indecisa tra dub, pop e jam rock, ma che finisce per restare in una terra di nessuno poco accogliente. Se in “Ghosts Of Tangier” il batterista ha modo di dare sfogo alla propria bravura senza che intorno accada molto di significativo, nelle tracce successive la rotta seguita non cambia; noi invece auspichiamo qualche evento che causi una virata verso altri lidi (la capacità di spaziare a questi musicisti di certo non manca), perché ad ascoltare questo disco ci siamo annoiati.
