THE BLACK ANGELS, Wilderness Of Mirrors
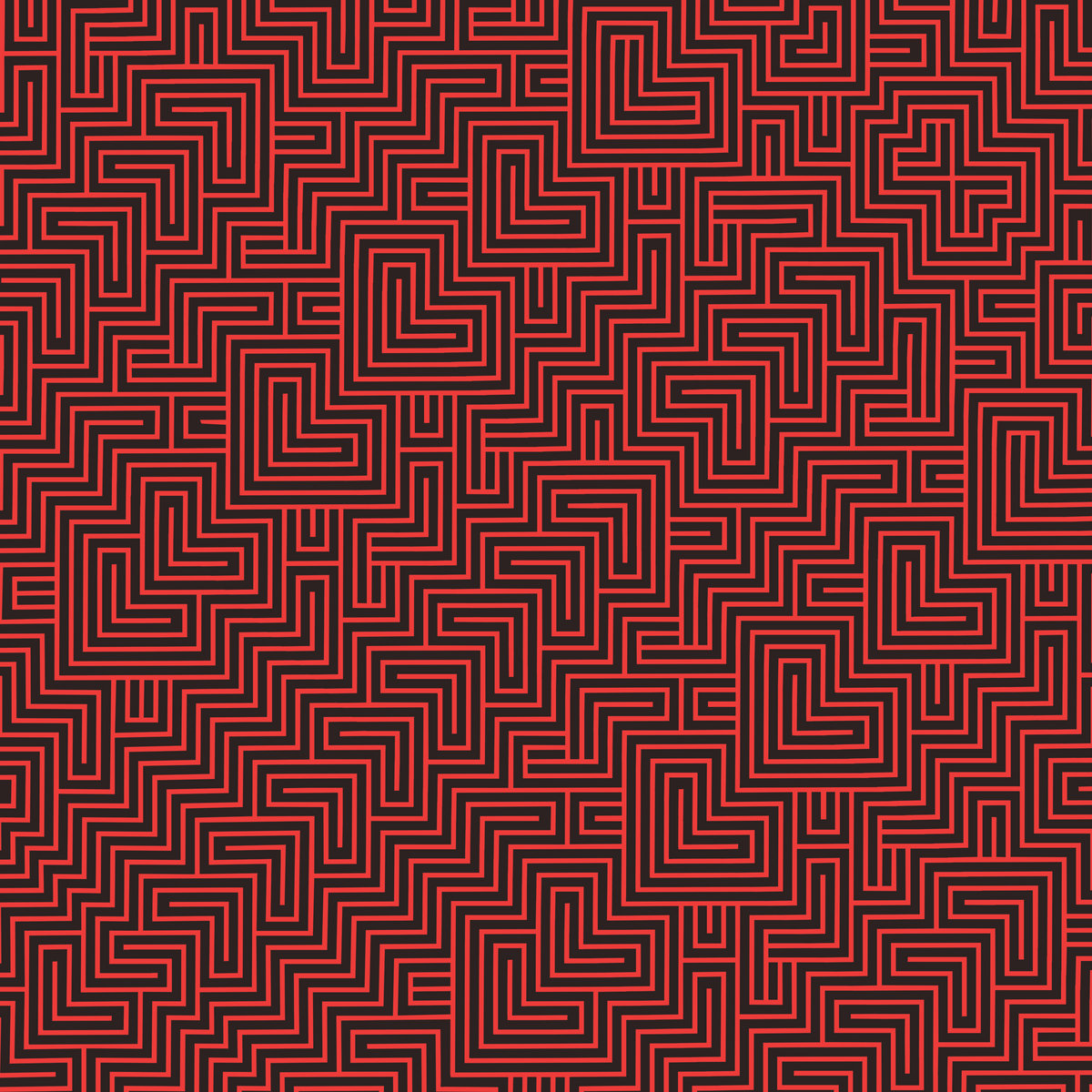
C’è stato un periodo in cui i Black Angels erano la band perfetta per risaltare il tratto stilistico tipico delle musiche del terzo millennio: la rielaborazione della nostalgia. Nel loro caso i riferimenti erano le visioni vampiresche di Roky Erikson, l’esoterismo cialtronesco di Jim Morrison, la ieraticità narcotica dei Velvet Underground. A questo si aggiungevano accenni al satanico hard-blues di là a venire. I Black Angels si rifacevano alle musiche a cavallo tra anni Sessanta e anni Settanta del secolo scorso, il momento in cui la controcultura giovanile anglosassone raggiungeva il suo punto apicale e stava per pagare un conto salato per i suoi sogni di rivoluzione: all’inizio degli anni Dieci funzionava e in un mondo alla ricerca di escapismo e di edonismo virtuale loro (e le loro dirette emanazioni: Reverberation Appreciation Society, Levitation, Austin Psych Fest) erano la testa d’ariete per la nuova generazione psichedelica.
Dall’esordio Passover del 2006 sono passati 16 anni, il trend psichedelico è pian piano scemato e i Black Angels, più fedeli alla linea dei CCCP, continuano imperterriti e devoti a celebrare lo stesso culto. Per quanto abbiano prodotto album di qualità (Passover, Directions To See A Ghost e il terzo, ineguagliato Phosphene Dream del 2010), la loro strada non è stata priva di mosse sbagliate e buchi nell’acqua: l’uscita del bassista Nate Ryan (poi nei The Shine Brothers) portò a un vero e proprio cambiamento nel sound della band e Indigo Meadow (2013) segnò un brutto cambio di passo, poi ci fu la riabilitazione nel 2017 con Death Song, anche se era chiaro come i bei tempi del “drone’n’roll” fossero belli che finiti.
Wilderness Of Mirrors sconta un’altra assenza importante, quella di Kyle Hunt, polistrumentista che aveva plasmato il sound di Phosphene Dream, ma si presenta all’appuntamento con la maestria che una carriera ventennale può garantire. Alex Maas salmodia e arringa, Christian Bland zig-zaga tra i riff, mentre Stephanie Bailey percuote le pelli come una sciamana nativa. È bello constatare che negli episodi più oscuri la band ancora sa tenere il tiro in palla (“Without A Trace”, “History Of The Future”, “La Pared”, “Empires Falling”) e sa ancora fondere fuzz e surf-rock (“Wilderness Of Mirrors”, “A Walk On The Outside”) e il pow-wow con il blues (“Icon”), nonostante le ballate e i momenti soft (“100 Flowers Of Paracusia”, “Vermillion Eyes”, “Suffocation”) siano in sovrannumero, così che la palpebra inizia a calare. Troppa carne al fuoco per un album dalla durata eccessiva, anche se con più luci che ombre. Un ritorno gradito, da queste parti.
