SIMON BALESTRAZZI, Redshift
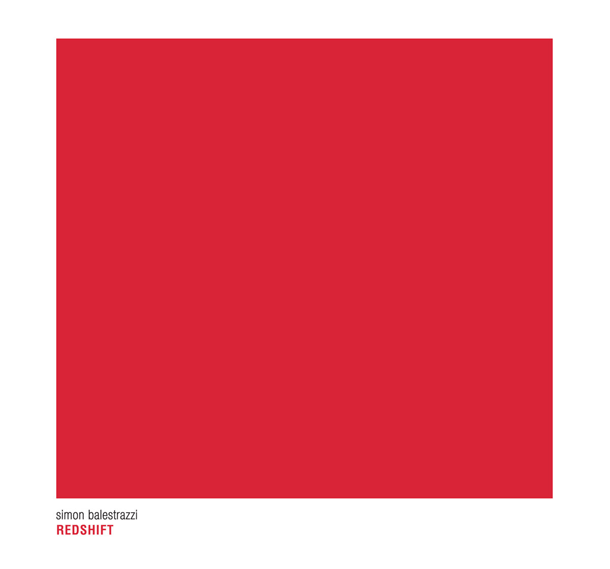
Nuovo album di Balestrazzi sulla sua Azoth, nuovo tema da sviluppare, come ogni volta. Qui la faccenda sembra più semplice del solito per lui (ma non per me), perché “Redshift” (“spostamento verso il rosso”) ha già a che fare col suo mondo, visto che è legato all’effetto Doppler, per cui se qualcosa si avvicina a te, osservatore statico, percepisci il suo suono come di frequenza più alta di quella che avrebbe se stesse fermo, mentre se si distanzia (“red shift”, quando invece parliamo di movimento della luce) la frequenza diventa più bassa. Il classico esempio concreto è quello di come senti in modo diverso la sirena di un’ambulanza quando ti passa vicino e quando poi si allontana. Dopo quattro pezzi titolati come il disco, in chiusura abbiamo anche l’antitesi, “Blueshift”, non a caso ben diverso dai precedenti.
Balestrazzi utilizza, sempre in una configurazione molto spoglia, diversi tipi di percussioni, lasciandosi guidare dalla sua idea di partenza: per questo, oltre che per il fatto che ha lavorato con Ikue Mori e Z’EV, vien voglia di raffrontare Redshift con la produzione di vari batteristi aumentati/estesi/espansi incontrati in questi ultimissimi anni, ad esempio Jason Van Gulick (e il suo mentore Lê Quan Ninh), ma la lista sarebbe lunga (Tomlinson, Aquarius, Weis…) e andrebbe anche più indietro nel tempo, includendo nomi associati alle pratiche dell’improvvisazione. Insomma, è possibile farsi bastare delle percussioni, suonate in modo non ortodosso e magari “truccate”, per realizzare qualcosa che stia in piedi da solo e non abbia a che fare col ritmo o con ritmi convenzionali: molto spesso, del resto, quasi per tutti il risultato ottenuto è atmosferico (Thomas Köner, considerato uno dei padri del c.d. dark ambient, per uno dei suoi primi dischi ricorse a dei gong, registrati in varie stanze, e non synth, campionatori o laptop). Le cose, però, non sono così ovvie: troppo facile riassegnare Balestrazzi a certi generi quando qui una fetta del disco parla una lingua diversa, la cui grammatica, se esiste o se qualcuno l’ha scritta, non ho studiato.
Da notare poi che Simon, quando inverte la sua direzione (“Blueshift”), cambia anche assetto e passa al [d]ronin, strumento artigianale e “su misura” del quale ha cominciato a servirsi: tutto giunge più elettronico e meditativo, non si cammina più sulle superfici scabre di prima.
Penso che in uno come me Redshift non possa che aumentare la curiosità di capire come funzionano musiche fuori dalla mia comfort zone, che già di suo tanto comfortevole non è. Sarebbe bello leggere il punto di vista di chi proviene dalla “contemporanea”, dal free jazz o dall’improvvisazione.
