Libero per un minuto. Steve Lacy 1965-1972

Informazione non è conoscenza. Conoscenza non è saggezza. Saggezza non è verità. Verita non è amore. Amore non è musica. La musica è il meglio (Frank Zappa)
Quello, a mio avviso, è il posto della musica; sul limite tra il noto e l’ignoto, ed è verso l’ignoto che bisogna spingerla, sempre, altrimenti è la sua morte, e la nostra” (Steve Lacy, in “Improvvisazione, sua natura e pratica in musica”, Derek Bailey, 1980)
L’articolo prende le mosse da Free For A Minute (1966-72), pubblicato dall’etichetta Emanem quest’anno: due cd, quattro sessioni.
La grande metafora
Dal Dixieland di Pee Wee Russell a Jazz Advance, l’album di debutto del 1956 di Cecil Taylor; dai lavori con (e poi su) Monk in solo, duo e trio alle indagini nuovamente in solitaria costruite su poco più di una singola frase interrogativa, ripetuta più e più volte, come in un mantra. L’unica volta che ebbi la fortuna di vederlo, Steve Lacy, era con la sua compagna Irene Aebi e oltre a suonare, come lui sapeva, il soprano, con quel tono nitido e pulitissimo, recitò alcune poesie. Ricordo ancora l’attacco dello spettacolo, che citava Burroughs: The river is served, sir. Se per lo ieratico William il linguaggio era un virus venuto dallo spazio, aperto ad ogni possibile contaminazione, così era per Steven Norman Lackritz. Ed infatti, come recitava lo slogan di apertura del festival Crossroads nel lontano 2001 (preso proprio da una delle tante e profonde riflessioni di Lacy), “il jazz è indipendenza e interdipendenza. Non c’è nulla di simile al mondo, non c’è altra attività che sia così radicalmente basata sull’invenzione collettiva […] Per il solo fatto di essere fondato su un impegno collettivo, il jazz diventa un soggetto molto interessante in termini allegorici. In fondo possiamo dire che il jazz è un virus, un virus di libertà, che si è diffuso sulla terra infettando tutto ciò che ha toccato: il cinema, la poesia, la pittura, la vita stessa”. Il jazz diventa la grande metafora.
“Tutta la musica viene fuori dalle parole” (affermazione estratta da “Conversazioni con Steve Lacy”, a cura di Jason Weiss, per le edizioni pisane ETS): per questo Lacy si è confrontato con i testi di Lao Tzu, Nanni Ballestrini, Elias Canetti, Jack Kerouac, e spesso e volentieri con la poesia d’avanguardia, come testimoniato dal lungo sodalizio con il reggiano Corrado Costa. Tra improvvisazione, performance, teatro, scultura, devozione a Monk (ma senza spirito calligrafico, piuttosto con l’intento sempre perfettamente esposto di scavare a fondo nell’intima essenza di quei temi immortali), free, bop, e l’elenco è per forza di cose solo arbitrario e parziale: Steve Lacy è stato un esploratore. Basti prendere, ad esempio, il disco per la svizzera Hat Hut a nome Steve Lacy And The New Jazz Meeting, intitolato Baden 2002. Come definire questa musica? Lacy amava spesso lavorare con chi non aveva radici nel jazz: in questo caso sono della partita, tra gli altri, Philip Jeck ai giradischi e Christof Kurzmann alle electronics, per uno degli ultimi progetti del musicista newyorkese. Il risultato è un’ora di suoni imprendibili, persi in un luogo che non sappiamo descrivere, un posto semplicemente misterioso. Come inafferrabile resta la bellezza intatta e austera dei temi monkiani riproposti al soprano in alcuni dischi targati Soul Note, come Only Monk (1987) e More Monk (1991).
Ora è da poco uscito un succoso cofanetto per Emanem, Free For A Minute, sul periodo 1965-1972, e valeva proprio la pena di indagarci un poco attorno: stiamo parlando di uno dei grandi irregolari del jazz, con i piedi saldamente ancorati nella tradizione, ma con testa, cuore e tecnica capaci di portarlo e portarci semplicemente altrove. Liberatevi per un minuto e, se non lo conoscete ancora, scoprirete un musicista letteralmente extra-ordinario. (Nazim Comunale)
Ultimi tempi a New York

Steve Lacy vantava un curriculum di tutto rispetto già agli albori degli anni Sessanta. Nel decennio precedente, ancora ventenne o giù di lì, aveva suonato nelle principali formazioni Dixieland della New York di quegli anni, dapprima studiando col sassofonista tenore Cecil Scott, poi incidendo vari dischi con i sestetti di Dick Sutton, Joe Puma e Withey Mitchell.
È Cecil Taylor a condurlo verso i linguaggi del nuovo jazz: nel 1956 suona in Jazz Advance, che del celebre pianista è l’esordio discografico. Si contano i primi ingaggi nelle formazioni allargate di Gil Evans, compresa tra questi l’esperienza nell’orchestra delle quiete notti di Miles Davis, ma soprattutto – svolta cruciale – acquisisce centralità lo studio della musica di Thelonious Monk, che sarà scrutata a fondo e senza sosta per i successivi cinquant’anni. Non a caso, Lacy incide i primi dischi a suo nome e due tra questi, Evidence e Reflections, contengono quasi soltanto brani scritti dall’eccentrico pianista. Con Monk ci suona pure, ad esempio in Big Band And Quartet In Concert, il live del 1963 alla Philarmonic Hall di New York. La sua principale occupazione, in quel periodo, è portare avanti un quartetto ancora una volta only-Monk, con Roswell Rudd al trombone, Dennis Charles alla batteria e una sfilza di bassisti nessuno dei quali in pianta stabile: lo si può ascoltare in una produzione targata Emanem, uscita soltanto dieci anni dopo con l’appropriato titolo di School Days.
Viaggio in Italia

Praticamente nessuno, all’inizio degli anni Sessanta, azzardava un repertorio basato sulla sola musica di Monk; una scelta piuttosto estrema, tale da non garantire un adeguato sostentamento. Così, nell’estate del 1965, Lacy prende un volo per l’Europa e, dopo un breve soggiorno in Danimarca, si sposta a Roma seguendo le tracce di altri esuli americani, tra cui quell’Alvin Curran che di lì a poco avrebbe preso parte alla temeraria esperienza di Musica Elettronica Viva. Mancano ancora cinque anni al definitivo approdo a Parigi e al raggiungimento di una relativa stabilità economica, ma già nel dicembre di quel 1965 registra Disposability: l’appuntamento è con Kent Carter al contrabbasso e Aldo Romano alla batteria, il luogo di ritrovo gli studi della RCA Italiana.
La Emanem lo ripropone oggi in versione restaurata, il che è certamente un bene, dal momento che l’album rappresenta un punto di svolta importante nella carriera (nella vita) di Steve Lacy. Disposability innesca quel “minuto di libertà” che la storica etichetta inglese, oggi di stanza in Spagna, vuole parzialmente esplorare, e sopratutto accoglie le prime quattro composizioni originali del sopranista americano, collocate accanto a cinque interpretazioni di classici firmati Monk, Cecil Taylor e Carla Bley. In brani come “Barble”, “Chary”, “M’s Transport” e “There We Were” ascoltiamo Lacy e i due sodali improvvisare sì liberamente, ma come indugiando tra l’immediatezza del caso e la necessità di una struttura, con il soprano di Lacy più volte tentato dalla citazione dietro l’angolo cui magari ammiccare. Come fossero sul filo del rasoio: un’immagine che, prese le giuste misure, potremmo applicare infinite volte alla musica di Lacy. Si coglie l’eco delle parole di Monk, bada alla melodia. Curiosamente, Lacy non farà mai più ritorno su queste prime composizioni, a conferma del loro carattere di tentativi, di prove e verifiche ancora troppo parziali: del resto, di fronte ai primi frutti del proprio lavoro, chi di noi non ha mai provato quella innocente forma di vergogna?
Non passano due mesi che il trio, con l’aggiunta di Enrico Rava alla tromba, diventa un quartetto. Il loro Sortie è il secondo, andando in ordine cronologico, dei quattro lavori proposti in Free For A Minute. Sei brani registrati negli studi Fonorama di Milano e usciti in origine nella Collana Free Jazz dell’etichetta GTA: in realtà paiono un’unica lunga improvvisazione, e parlano una musica decisamente più torrenziale rispetto a quella contenuta nell’ancora incerto Disposability. Di esposizioni tematiche, vuoi anche per il contributo di un Rava ancora lontano dal clima esotico e psichedelico del suo album-manifesto Katcharpari, non c’è nemmeno l’ombra: siamo insomma in piena new thing, in un vortice di impurità e di spontanea ricerca timbrica. Un sopralluogo effettuato con riserbo, che sconfina in un terreno a rischio frana tra tonalità e a-tonalità. Va detto che quella stessa formazione – insieme tra gli altri a Don Cherry e Gato Barbieri – aveva appena partecipato alle registrazioni di un caposaldo del free jazz italiano, vale a dire la suite Nuovi Sentimenti del compositore e pianista Giorgio Gaslini (anche autore di colonne sonore, tra le quali una parte di “Profondo Rosso” di Dario Argento e “La Notte” di Michelangelo Antonioni), la cui definizione di musica totale, volta alla ricerca di incastri chimici tra linguaggi diversi, ben si addice alla dimesione ludica e conoscitiva di un musicista curioso e instancabile come Lacy.

Sono questi i primi tasselli di un mosaico, quello che ritrae il rapporto tra Steve Lacy e l’Italia, che con gli anni non ha fatto che infittirsi. La collaborazione col batterista Andrea Centazzo, il sassofono fiabesco prestato a quel Bestiario di Maria Monti fresco di ristampa, le due avventure con gli Area, gli innumerevoli dischi in formazioni varie per etichette quali Black Saint, Soul Note, Cramps, Horo e via dicendo. E poi il solido legame con la città di Pisa, stretto negli anni Settanta tra i tumulti degli autoriduttori e suggellato un decennio più avanti dal conferimento della cittadinanza onoraria. C’è posto anche per una esibizione all’edizione del 1966 del Festival Jazz di Sanremo; immaginate un po’ come andò a finire… E come non citare i film girati da Ciprì e Maresco, due tizi che di jazz se ne intendono? Si tratta di una breve videointervista e di un documentario intitolato “Steve Plays Duke” (Ellington, ovviamente).
Con il coltello tra i denti
Devo andare a casa ad ascoltare Vivaldi tutta la notte. Questi suonano con il coltello tra i denti
Queste parole non proprio lusinghiere sono di Astor Piazzolla, il celebre rivoluzionario del tango. Le stampa chiare e tonde in un articolo di giornale dopo aver assistito a una performance argentina del quartetto free jazz di Steve Lacy, che si tiene nell’estate del 1966 al fianco di Enrico Rava, del bassista Johnny Dyani e del batterista Louis Moholo. Il biglietto per Buenos Aires glielo aveva procurato l’allora moglie Rava, di origini appunto argentine: dovevano suonare a incasso, in un teatro, per due settimane di ingaggio e con un biglietto dell’aereo, beninteso, di sola andata. Prima di racimolare il necessario per farne uno di ritorno, passeranno ben nove mesi tra concerti il più delle volte mal capiti e situazioni memorabili, scossi inoltre – loro e il Paese intero – dallo stallo che il colpo di stato del generale Oganía aveva nel frattempo causato. Un’esperienza da ricordare, insomma, di quelle che si prova piacere a raccontare proprio perché è stato duro, o quantomeno singolare, viverle.
Chissà se Piazzolla ci ha poi ripensato, se su quella musica così ostica ha cambiato o meno opinione (si direbbe di sì). Non solo l’Argentina di allora, imbrigliata tra crisi politiche e instabilità sociale, non aveva ancora saputo accogliere il verbo che era stato di Ornette Coleman e Albert Ayler, ma il bello è che di quella musica il quartetto di Lacy suonava una versione in qualche modo diversa, quasi a sé stante. Si ascolti il disco-simbolo della difficile permanenza in Sud America, pubblicato nel 1967 dalla storica ESP Disk a nome The Forest And The Zoo: due lunghi brani di improvvisazione libera e totale, per una musica che, però, ha poco della veemenza incendiaria di molti capolavori del genere, pur essendone una pietra miliare. Ad ogni modo è il picco della fase puramente free di Steve Lacy, quello che si direbbe il punto di non ritorno.
Jazz in caduta libera
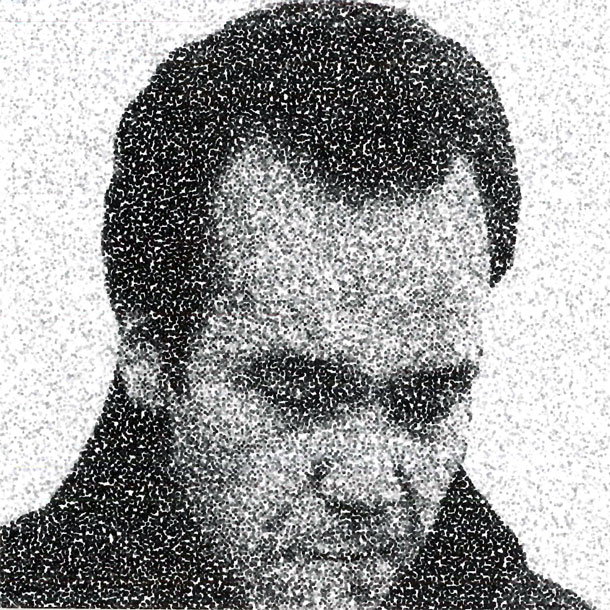
Ci siamo già soffermati su quanto sia encomiabile il lavoro svolto da Martin Davidson nella cura di questo Free For A Minute? L’uomo dietro ad Emanem ha migliorato la qualità audio e apportato precisazioni di vario genere. La vera sorpresa consiste però nei due lavori inediti, vale a dire una colonna sonora – per il film Free Fall, poi mai prodotto – e il materiale (ne parliamo tra poco) estratto da una breve seduta in quintetto risalente al 1972.
Va detto che la soundtrack di questo film fallimentare, registrata a New York nel 1967 di ritorno dall’Argentina, è talmente breve e abbozzata da lasciarci con l’amaro in bocca. Peccato. Si tratta infatti di un unicum nella discografia di Steve Lacy, per via di una formazione, mai più ascoltata, in cui gli immancabili Rava e Carter danno il benvenuto al vibrafono radioso di Karl Berger e alla batteria di Paul Motian, disarticolata e febbrile allo stesso tempo. Lacy deve imporre dei limiti: lavorando su dettato delle immagini, non era più possibile improvvisare in un idioma totalmente libero. In un’intervista del 1971 a Jazz Magazine, dirà che “quello che si ottiene autolimitandosi è la vera libertà”. È un primo segnale di quel linguaggio poly-free che il sassofonista svilupperà nel corso degli anni Settanta e che troverà la sua massima espressione in formazioni quali il quintetto o il sestetto.
Questa musica chiamiamola Roba
La permanenza a New York andrà avanti per pochi mesi ancora. Giusto il tempo di registrare, nel febbraio del 1968, l’epocale A Genuine Tong Funeral dell’orchestra di Gary Burton e Carla Bley, oltre al capitolo della Jazz Composer’s Orchestra firmato Michael Mantler. Poi di nuovo Roma, in un primo momento facendo tappa a Trastevere, nello “studio” di Musica Elettronica Viva, a dire il vero un’ex fabbrica di materassi tramutata in quello che oggi chiameremmo uno squat. Il che non corriponde a un’astrazione totale dalla temperie del periodo: del resto siamo nel Sessantotto, e il collettivo avviato da Frederic Rzewski, Richard Teitelbaum e Alvin Curran rappresenta tanto una sorta di rumorismo ante litteram, quanto un programma radicale di contestazione politica aperto al contributo di tutti.
Un’altra ipotesi realizzata sulla scia di MEV è un lavoro del 1969 registrato dal vivo nella galleria “L’Attico” di Fabio Sargentini. Vi partecipano Enrico Rava alla tromba, Claudio Volonté al clarinetto, Italo Toni al trombone, Irene Aebi al violoncello e Carlo Colnaghi alla batteria. Il disco – due lunghe tracce di una musica squilibrata, rarefatta e impenetrabile – esce soltanto nel 1972 sulla francese Saravah con l’emblematico titolo di Roba. Roba è l’esito di un concetto sviluppato nel contesto di Arte Povera, il movimento artistico che, proprio sul finire dei Sessanta, aveva riunito le avanguardie radicali dei vari Kounellis, Boetti, Pascali e via dicendo. Un concetto, quello di Roba, figlio della passione linguistica di Lacy e spiegato dallo stesso in una lunga intervista pubblicata nel 1976 sulla rivista d’arte Parachute: “Roba (in italiano, ndr) vuol dire mille cose, una situazione, un oggetto, un materiale, una musica, una droga, qualsiasi cosa”. Musicisti, professionisti e non, suonano per ore una musica senza barriere né misure. La forma solo come accade. Non deve comunicare un bel niente, non significa altro se non sé stessa: è sufficiente che sia cotta a puntino, per usare la metafora del cibo tanto cara a Lacy e che, ad esempio, troviamo in bella vista nelle copertine di Stalks e Staples. In poche parole, ciò che conta è che questa musica venga bene.
The Rush & The Thing
L’ultimo dei quattro dischi di Free For A Minute chiama a raccolta le versioni inedite di due brani – The Rush e The Thing – a nome di un quintetto che registra la presenza di Noel McGhie (batteria) e Steve Potts (sax contralto), insieme ai soliti Aebi e Carter. Per Potts è una delle primissime avventure nei gruppi del di Lacy, di cui diverrà membro stabile e figura fondamentale. Qui è particolarmente in vista, mentre Lacy, quasi volesse identificarsi nel comportamento di una mantide religiosa, è situato sullo sfondo o svolazza tra gli interstizi, nascosto ma indispensabile. Altrove, ad esempio nell’esporre il tema, i due suonano in unisono ma con intonazioni leggermente distanti; così nell’incipit ostinato di The Rush. L’altro brano, che in questa sessione è stato diviso in due parti, insiste sul nostro famoso minuto di libertà. E ha del curioso: l’iniziale aria di sospetto, uno Steve Potts rabbia e spigoli, il violoncello da capogiro della Aebi, McGhie con un drumming da frontale sul naso; addirittura, in background, le frequenze impostate male di una radio.
The Rush e The Thing risalgono al periodo in cui Steve Lacy inizia a produrre la gran parte delle sue composizioni; lo stesso periodo dei pioneristici concerti in solo e delle prime canzoni con la voce della moglie e i testi di poesia beat, o legati alla filosofia Zen. Poi la musica spiccherà il volo e pian piano andrà delineandosi la figura di un musicista che in vita ha raccolto meno di quanto, generosamente, con perseveranza e dedizione, ha seminato. (Davide Ingrosso)
Si ringrazia Martin Davidson per averci lasciato usare alcune immagini interne di Free For A Minute (1966-72).
Bibliografia
Jason Weiss, Conversazioni con Steve Lacy, 2006, Duke University Press (in Italia pubblicato da Edizioni ETS nel 2016)
Molotov Jazz, in Valerio Mattioli, Storia segreta della musica italiana, 2016, Baldini & Castoldi
Enrico Rava, Incontri con musicisti straordinari, 2011, Feltrinelli
Discografia aggiornata di Steve Lacy al seguente link
