ARIEL KALMA, French Archives 1977-1980, Black Sweat Records
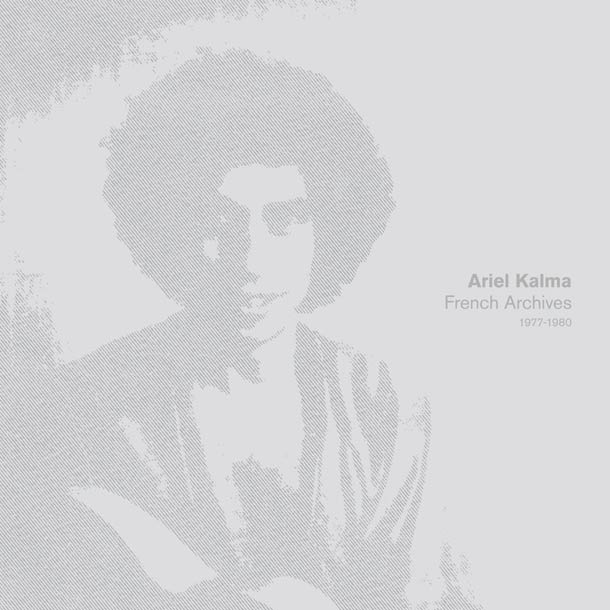
Un carillon di poche note perse a galleggiare come nuvole in acido nel cielo grigio di un’alba di fine anno (oggi pioveva quasi in orizzontale su queste terre aride eppure allagate, ho immaginato una scena da quadro di Magritte, con cani in cappottino e ombrello al posto degli uomini con la bombetta: “Entrance K7” ne era la perfetta colonna sonora). Un gioco di specchi e di sfasamenti, cocci rotti, profili che si inseguono e si deformano, le paure e le meraviglie di quando sei bambino, quel senso di endless summer e di infanzia mitologica che arrivava dai dischi di Fennesz e dei Boards Of Canada, quell’imprendibile nostalgia di qualcosa che non si riesce bene a dire, ognuno perso nei labirintici corridoi del suo personalissimo Overlook Hotel. Danny, vuoi giocare con noi? Le tastiere sottili e ossessive ci riportano a un passato ignoto a cui sappiamo di appartenere, saranno i suoni dei videogiochi dei primi anni Ottanta, saranno le sigle del tg, saranno le annunciatrici della tv, archeologia del passato prossimo, psicoacustica, atlanti farmacologici, mappe bruciacchiate di ricordi, foto fatte col grandangolo della memoria, fauna del fondo, effetti collaterali a scoppio ritardato, ma queste tutto sommato scolastiche ipotesi reiterative e circolari risultano all’inizio molto affascinanti. Una batteria elettronica da rigattiere, un ritmo elementare, una frase minimalista che semplicemente non smette mai, e il gioco è fatto: e il bello è che funziona, che somiglia alle biglie con la faccia dei ciclisti con cui si giocava in spiaggia nei lidi del tristissimo Mare Adriatico, un gioco che sa di corrieri cosmici, di strategie oblique, di colonna sonora perfetta per un Herzog d’archivio. Del resto, lo abbiamo già detto, la suggestione, semplicemente è tutto. La sempre attenta Black Sweat Records, dopo aver (ri)portato alla luce DSR Lines e Telaio Magnetico, ricomincia a diffondere l’opera di Ariel Kalma, musicista francese attivo da oltre quarant’anni, ora residente in Australia.
Nei quattro lp risalta anche “Slow Space Rumba”, desolata ipotesi lunare per una “Caravan” di Ellington rivisitata da androidi tuareg, che si apre su lunghi piani sequenze. Ci sono poi con due brevi flash di un paio di minuti, la massiccia “White Space” e l’enigmatica “Space Morse”. Molto più interlocutorio l’lp intitolato Astral Cathedral, che si apre invece sui flauti in pericolante bilico sulla new age di “Fource Et Courage”, per poi regalare il drone vocale di Slow Trancing; alcuni momenti sono prescindibili, ma “Anja Vision”, ad esempio, regala belle planate, con un clima che sa di invocazione rituale, anche se in alcuni frangenti prevalgono svisate di synth che lasciano un po’ il tempo che trovano. Planet Air ci propone invece due lunghe composizioni di stasi orizzontale ed estatica che richiedono molta dedizione per non skippare alcune parti. Sarasvati Planet ha invece bei numeri, come l’incrocio tra Riley e Wyatt di “Planet Ariel”, tra drone estatici e fioriture vocali, o le ipotesi circolari di Pas Ternelle (sebbene non manchino anche qui i passaggi a vuoto, come “Flamadanse”, incerta e sfocata).
Vent’anni fa avrei perso la testa per questo tipo di suoni: ora che ne ho ascoltati e digeriti a bizzeffe, riconosco il valore documentale importante di una così corposa retrospettiva, ma devo dire che, dopo un poco, la mia soglia di attenzione si abbassa. Se la raccolta fosse stata condensata in un doppio invece che in un quadruplo, sarebbe stata perfetta. Così invece risulta un poco dispersiva, ma è comunque in grado di offrire visioni agli occhi di chi sa aprirli verso dentro, nella miglior tradizione del cinema per l’udito, anche se qualche volta si sconfina pericolosamente in territori new age dove non mi sento molto a mio agio, nonostante la natura intimamente terapeutica della musica proposta.
