ANDREA GROSSI BLEND 3, Lubok
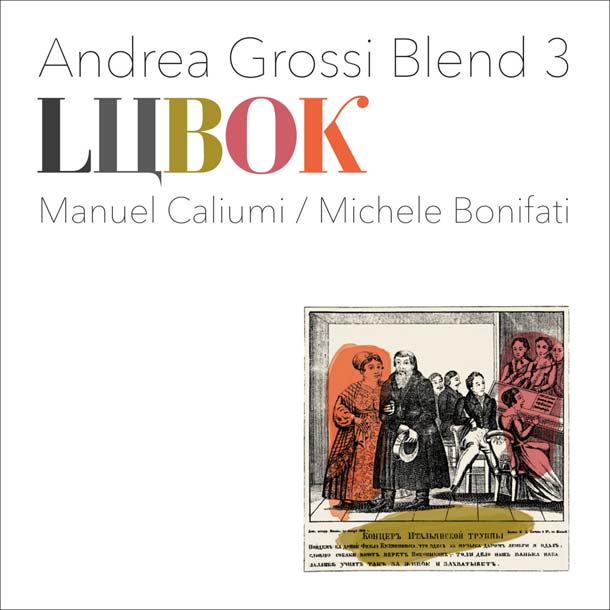
Si entra subito in medias res con “Prologue” e sentiamo dal primo istante che questo cielo manterrà la pioggia che promette: una veglia tesa, un mood circospetto, minacce a incombere e alfabeti indecifrabili, segnali. Il lubok era un tipo di stampa popolare diffuso in Russia nell’Ottocento; la sovrapposizione tra le scene e le macchie di colore ha suggerito ad Andrea Grossi l’input per dare vita a questo progetto in trio, dove il lubok è significante della sua attuale fase di ricerca, in cui attinge da tutte le tradizioni musicali del Novecento, mantenendo però spirito felicemente inquieto e occhi (e orecchie) spalancati verso un futuro di nuvole ancora da dire.
Il leader del progetto è un giovane contrabbassista di Monza, accompagnato qui dal chitarrista modenese Michele Bonifati e dal sassofonista carpigiano Manuel Caiumi. Il loro disco d’esordio si intitola proprio Lubok ed è semplicemente magnifico: un lavoro maturo e senza alcun compromesso, che mostra musicisti capaci di confrontarsi senza patire alcun timore reverenziale con il linguaggio dei giganti (Ornette Coleman, Tim Berne, quest’ultimo un faro in alcuni frangenti, ad esempio come nei triangoli scaleni del pezzo “MC”). Pubblica la We Insist! Records, una nuova etichetta che ha già dato alla luce, tra le altre cose, St()ma di Cristiano Calcagnile, un mistero radioso per set di batteria espansa, una discesa nelle viscere della terra e nella psiche che, vista dal vivo nell’ultima edizione del Ground Music Festival organizzato da Gabriele Mitelli, ha rapito tutti i presenti. Linee sghembe e millepiani filosofici e paralleli, rizomi, temi che sanno scovare sempre la melodia più obliqua e imprendibile, satori, lampi (“Mendicus”). Si procede in un buio denso ma senza alcuna incertezza, con un perfetto controllo e un’attitudine zen grazie alla quale ogni singola nota è al tempo stesso lieve come piuma e pesante come piombo, ogni minimo gesto sonoro dice, racconta, significa. Il profilo su cui indugia la chitarra di Bonifati (ottima, mai didascalica, sempre ficcante e sottile, personale, capace di inventare domande, delicata e appuntita, mai leziosa) nella seconda parte di “Mendicus”, ad esempio, mentre il contrabbasso si dilegua e il sassofono si lancia in dialoghi con il vuoto, in una nebbia che ha del magico.
Assolutamente vincente la scelta di suonare senza la batteria: si aprono spazi sconfinati, le dinamiche sono libere e fluide, un clima cameristico e sorvegliato aggiunge mistero al mistero (“Iwato”), tra scrittura e improvvisazione. Blend3 non sa quanti brani suonerà o quanto improvviserà, conosce soltanto il suo bisogno primario: prendere nuovamente vita ricercando un costante senso di unicità (così il libretto del cd). Nell’immagine in copertina è raffigurata una coppia che fa per uscire da una stanza dove una compagnia italiana sta suonando “Andiamocene a casa, Fela Kuzminsna! Che razza di musica è? Ho buttato via i miei soldi. Sembrano cani che ululano davanti a un morto… Vuoi mettere il nostro Van’ka?! Quando suona la balalajka ti fa venire la pelle d’oca!”. In questa stanza, da quando ci è entrato, chi scrive ha invece trovato modi e motivi per perdersi più e più volte (l’ipnosi nera, quasi ambient ,che a metà del romanzo avvolge e travolge le pagine di Ru-bok, come una rivisitazione in chiave cyber punk dei deliri della Chappaqua Suite di Ornette, colonna sonora del fantastico film di Conrad Rooks): che razza di musica è questa, ce lo possiamo chiedere legittimamente anche noi, e risponderci semplicemente: musica bellissima, pensata con cuore e testa, benedetta da una scrittura nitida ed ispirata, abitata da un vivo sentimento dello spazio e capace di sporgersi sul bordo dell’abisso, senza paura di quello che sta un passo, una virgola, una nota, un silenzio, una (vana) parola, più in là. Da quando Plutone ha rapito Persefone, quindi da quando la parola si perde nelle nebbie del mito, viviamo nell’Ade e cerchiamo a tentoni segnali per ritrovare un senso, una direzione. In questo disco si mette in scena in modo perfetto proprio questo disorientamento: fertile, privo di qualsiasi autocompiacimento, controllatissimo (nelle viscere della terra bisogna muoversi con economia di gesti e dinamiche calibrate, ogni passo è vitale), denso di scintille creative. Come in un viaggio dantesco, siamo nel limbo, e sappiamo che un giorno potremo dire “al fine uscimmo a riveder le stelle”. È nata per davvero una stella: speriamo che gli osservatori jazzonomici non se ne accorgano tra troppi anni luce.
